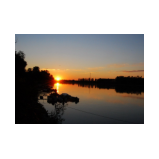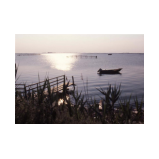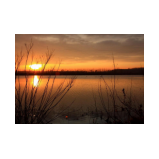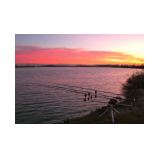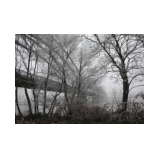Il Fiume Po

Descrizione
Con una lunghezza di oltre 650 Km , il Po è il fiume più
lungo d’Italia. La sorgente è posta a Pian del Re, ai piedi del Monviso, a 2022 metri di quota.
Nel suo percorso dalle Alpi
piemontesi all’Adriatico, il Grande Fiume raccoglie acqua da ben 141 affluenti.
Il suo è il più grande bacino idrografico italiano (oltre 71.000 Km quadrati) e
comprende ben sei regioni, oltre 3.200 comuni ed una popolazione di circa 16
milioni di abitanti.
La foce è posta a nord di
Ravenna. Nell’ultimo tratto del suo percorso il Po si divide in cinque bocche
(Po della Maestra, Po della Pila, Po di Tolle, Po della Gnocca, Po di Goro) che
formano un delta di 380 Km
quadrati
Un milione di anni fa, nell’area
attualmente occupata dalla pianura padana, si trovava un mare delimitato dai
rilievi alpini ed appenninici. L’erosione provocata dalle piogge iniziò a far
depositare detriti sul fondale marino. Nel frattempo, circa 400.000 anni fa, la
crescita dei ghiacciai provocata dalle glaciazioni contribuì ad accelerare questo
processo.
20.000 anni fa, al culmine del
periodo glaciale, le acque del mare si trovavano circa 100 metri più in basso
rispetto al livello attuale. Di conseguenza, quello che prima era il fondo del
mare emerse e divenne una pianura alluvionale estesa fino all’altezza di
Ancona. All’epoca il Po ed i suoi affluenti erano corsi d’acqua poco profondi,
larghi alcuni chilometri e senza un alveo ben definito. Il loro percorso
attraversava una pianura alluvionale con una vegetazione simile a quella attualmente
presente nel nord della Scandinavia. Con la fine delle glaciazioni, 18.000 anni
fa le temperature risalirono portandosi a livello simili a quelli attuali ed
anche il livello del mare risalì e tornò ad impossessarsi di parte del
territorio emerso.
Con il passare del tempo,
l’aspetto del territorio padano si avvicinò sempre più a quello attuale. 5.000
anni fa, ad esempio, la linea costiera si trovava circa 10-15 km all’interno rispetto ad
oggi. L’opera di deposito del Po prosegue senza sosta. I detriti trasportati
dal Po fanno avanzare il delta di qualche decina di metri l’anno.
Nel corso dei secoli, il Po ha
cambiato il suo percorso ma anche il suo nome. Per gli antichi greci, il Grande
Fiume era l'Eridano, presso gli antichi Liguri era invece chiamato Bodinco. Con
la conquista dell'Italia settentrionale da parte dei Galli, infine, assunse il
nome celtico Padus.
Il Grande Fiume rappresenta da
sempre una grande risorsa per le popolazioni del nord Italia, che hanno cercato
di controllarne le acque per utilizzarle per le proprie attività. In
quest'ottica, gli eventi di maggior rilievo sono quelli dove più si esplica la
lotta fra l'uomo e le forze della natura: le piene.
Sin dall'antichità si è cercato
di costruire argini per sottrarre terreno alle paludi e dare al Po ed ai suoi
affluenti un corso ben definito. Dopo la fine del periodo romano, durante il
quale erano state effettuate mirabili opere di bonifica, il degrado che
caratterizzò l'alto medioevo permise ai boschi ed alle acque stagnanti di rimpadronirsi
di buona parte del territorio. Fu solamente intorno all'anno 1000 che si
riprese a costruire argini, che però erano isolati. Fu solamente nel 1479 che
le operazioni di arginatura furono completate ed il corso del Po fu ricondotto
ad un solo alveo.
Nonostante gli sforzi degli
abitanti della pianura padana, nel '500 il Grande Fiume ruppe ripetutamente gli
argini (ben tre volte nella sola zona di Carbonara) e causò molti danni. Le
guerre che colpirono il mantovano nel '600 e nella prima metà del '700 portarono
ad un abbandono delle opere di bonifica e questo rese ancora più frequenti le
alluvioni.
In tempi più recenti, nel basso
mantovano sono da ricordare le drammatiche rotte del Po del 1771 (tra Carbonara
e Sermide) e del 1839 (due volte a Bonizzo nel giro di due mesi). Dopo l'unità
d'Italia si effettuarono ulteriori lavori che sostanzialmente portarono il
fiume ad assumere il corso attuale. Nel carbonarese, ad esempio, nel 1870 si
spostò l'argine maestro verso nord creando quella che è l'attuale golena.
Le ultime grandi rotte nel basso
mantovano risalgono proprio a quel periodo. Il 23 ottobre 1872 il Po ruppe gli
argini a Revere creando una breccia di 250 metri . A causa delle
piogge insistenti, il fiume tornò ad allagare le campagne anche nel mese di
novembre e a dicembre. Il 4 giugno 1879, infine, un fontanazzo creò una breccia
di 30 metri
a Borgofranco. La rotta si allargò rapidamente e distrusse 300 metri di argine.
Senza trovare più alcun ostacolo, le acque si riversarono nei campi dove
distrussero i raccolti ormai maturi.
Da allora le piene principali si
ebbero nel 1951, con la terribile alluvione del Polesine, nel 1994, quando a
finire sott'acqua furono ampie zone del Piemonte, e nel 2000, quando il livello
del fiume batté ogni record causando ingenti danni lungo tutto il suo corso.
La fauna
Intorno al Po si sviluppa un
ricco habitat naturale che, nonostante l’influenza delle attività umane,
conserva ancora tratti caratteristici.
Tra i pesci, i più comuni sono il
luccio, la carpa e la tinca. La zona delle sorgenti, inoltre, è una delle poche
aree dell’Italia settentrionale dove si può trovare il gambero di fiume.
All'interno della fauna acquatica, un discorso a parte va invece fatto per il
pesce siluro, specie proveniente dall’Europa centro orientale ed apparsa nel
Grande Fiume nel corso degli anni ’80. Il siluro ha trovato nel Po un ambiente
ideale, che gli ha permesso di riprodursi e che consente ad alcuni esemplari di
raggiungere dimensioni enormi (oltre 100 kg di peso per più di due metri di lunghezza).
Simile ad un grosso pesce gatto, il siluro si nutre di altri pesci, di anfibi
ed uccelli acquatici ma la sua presenza ha un’influenza negativa sulle specie
autoctone.
Lungo il Po sono presenti anche
numerose specie di anfibi e piccoli roditori. In prossimità delle rive vivono
anche volpi, tassi, lepri e donnole.
Tra gli uccelli, infine, sono
molto comuni le garzaie, gli aironi cenerini, le garzette, le nitticore e
moltissimi passeriformi. Più rari ma comunque presenti sono anche l’airone
rosso, la pavoncella, la poiana, il gufo comune, il falco di palude, il
gruccione, il picchio rosso maggiore e il picchio verde.
E' praticamente inutile dire che
l'attività dell'uomo ha quasi completamente fatto scomparire la flora spontanea
tipica della Pianura Padana. Oggi la maggior parte della vegetazione che cresce
nella valle del Po è frutto di coltivazioni. Tuttavia in alcune zone, molte
delle quali inserite in Riserve naturali, l'ambiente naturale si è conservato
almeno in parte intatto.
Nel territorio padano, i
principali fattori ambientali che determinano l’affermarsi di un tipo di bosco
rispetto ad un altro sono:
1) l’azione dei fiumi (deposito
di alluvioni sabbiose/limose, erosione di tratti di sponda, piene primaverili e
autunnali).
2) nelle aree non soggette alle
dinamiche fluviali, la presenza/assenza di acqua negli strati più superficiali.
Nelle zone vicine ai fiumi si
sviluppano soprattutto salice bianco, pioppo bianco, pioppo nero, gelso,
farnia, carpino, frassino e olmo. In quelle lontane dai corsi d'acqua, sono
diffusi soprattutto farnia, carpino bianco, pioppo nero, acero campestre, olmo
campestre e ciliegio selvatico. Nelle aree paludose ma lontane dai fiumi,
infine, si trovano prevalentemente ontano nero, salice bianco, pioppi e frassino
ossifillo.
Nel corso del tempo, i processi
di interramento legati all'azione di deposito dei corsi d'acqua ed agli
spostamenti dei loro alvei creano un'alternanza fra i vari tipi di vegetazione.
Il Po ed i suoi affluenti, insomma, non modificano solo il territorio ma anche
la flora e, di conseguenza, sono tra i principali artefici del paesaggio e
dell'ambiente della Pianura Padana.
Le Piene
La storia del Po è anche una
storia di piene ed alluvioni. È l’altro volto del Grande fiume, che da sempre è
una risorsa insostituibile per gli abitanti dell’Italia settentrionale ma che è
anche capace di incutere timore e di provocare disastri e danni ingenti.
A livello storico, la prima piena
nota è quella del 108 a .
C., il cui ricordo è giunto fino a noi grazie alla descrizione fattane da
Cluverio Filippo. Un’altra alluvione rimasta negli annali è quella di Ficarolo
del 1150, in
seguito alla quale il fiume modificò addirittura il suo corso. Nel corso dei
secoli, l’uomo riuscì ad imbrigliare con efficacia crescente le forze della
natura ma, anche oggi, il Po è in grado di rompere gli argini, come è avvenuto
in Polesine nel 1951 o in Piemonte nel 1994.
Confrontando gli eventi
alluvionali verificatisi nel corso degli ultimi due secoli, è stato possibile
identificare alcuni elementi ricorrenti. Le piene del Po generalmente sono
dovute a forti precipitazioni in Piemonte e nella Lombardia occidentale causate
dall’azione di blocco di un’alta pressione sull’est europeo. La presenza di
tale anticiclone impedisce alla perturbazione di lasciare con rapidità il nord
Italia e questo provoca consistenti piogge, spesso alimentate da intense
correnti di scirocco. Le elevate temperature causate dai venti meridionali
innalzano il limite delle nevicate sulle zone montuose e, contemporaneamente,
provocano lo scioglimento di considerevoli quantità di neve, che alimentano
ulteriormente il Grande fiume. Negli episodi più drammatici, inoltre, a questi
fattori si sono sommate elevate precipitazioni nelle settimane precedenti, che
hanno contribuito a limitare la capacità di assorbimento del terreno e ad
innalzare l’umidità dell’aria, con conseguente riduzione dell’evaporazione.
Curiosamente, in corrispondenza
delle principali alluvioni della storia, a Mantova non è mai piovuto molto. Nel
1951, ad esempio, sulla città dei Gonzaga caddero solamente 39,3 mm di pioggia a
settembre (media 60,5 mm ),
42,1 mm
ad ottobre (media 78,1 mm )
e 72 mm
a novembre, il mese della piena (contro i 236 mm caduti mediamente in
tutto il bacino del Po).
Le piene, in ogni caso, possono
essere provocate da precipitazioni di durata molto diversa. La disastrosa
alluvione del 1951, ad esempio, fu causata da 7 giorni di pioggia. Due anni
dopo, invece, 18 giorni di pioggia provocarono un’altra piena ma di dimensioni
decisamente inferiori.
La primavera e l’autunno sono i
periodi nei quali è più probabile il verificarsi di eventi alluvionali. Nel
corso del ‘900, il mese con più episodi di piena fuori dalla norma è stato
novembre, seguito da ottobre, maggio e giugno.
Ci sono eventi che, per
l’importanza, l’emozione suscitata o la drammaticità, rimangono nella memoria
collettiva di un’intera generazione. La piena del 1951, che culminò
nell’alluvione del Polesine, è sicuramente uno di questi. È la piena dei nostri
nonni, il metro di paragone di tutte quelle successive, una storia che chi vive
in riva al Grande fiume si è sentito raccontare in mille occasione ed ogni
volta con nuovi aneddoti legati alle esperienze personali di ogni singolo
testimone.
Le storie legate a quei terribili giorni di novembre, per quanto spesso apparentemente ingigantitesi negli ormai oltre 50 anni di distanza, sono in realtà in buona parte veritiere. Mai, da quando si iniziò a raccogliere dati, le acque del Po avevano fatto raggiunto livelli simili. Mai, negli ultimi secoli, una piena aveva causato danni così ingenti.
Le storie legate a quei terribili giorni di novembre, per quanto spesso apparentemente ingigantitesi negli ormai oltre 50 anni di distanza, sono in realtà in buona parte veritiere. Mai, da quando si iniziò a raccogliere dati, le acque del Po avevano fatto raggiunto livelli simili. Mai, negli ultimi secoli, una piena aveva causato danni così ingenti.
Il processo che portò ad un
evento di tali dimensioni ebbe inizio alcuni mesi prima. Nel periodo compreso
fra l’agosto e l’ottobre del 1951, infatti, abbondanti precipitazioni sulle
Alpi occidentali e sugli Appennini contribuirono a ridurre la capacità di
assorbimento del terreno. Poi, tra il 7 ed il 13 novembre, due perturbazioni
distinte, la prima di origine atlantica e la seconda proveniente dall’Africa
settentrionale, provocarono diffuse ed intense piogge su tutta l’Italia. In
quei giorni, sull’intero bacino del Po caddero 17 miliardi di metri cubi
d’acqua (la quantità che mediamente viene accumulata in sei mesi), ai quali si
aggiunsero quelli generati dallo scioglimento delle nevi per le alte
temperature dovute a venti meridionali.
I primi gravi allagamenti si
verificarono il 12 novembre nell’Oltrepo pavese, nel cremonese e nel
piacentino. Mercoledì 14 novembre, la pressione della piena dell’affluente
Crostolo, non ricevuta dal Po, ruppe gli argini a poche centinaia di metri dal
punto di confluenza, in corrispondenza di Gualtieri (Re). Il riflusso del Po fu
violentissimo e l’intera cittadina fu allagata.
Nei giorni successivi l’onda di
piena procedette inesorabile verso valle. Nella notte tra il 14 ed il 15
novembre si verificarono le prime tracimazioni nel rodigino, a Paviole e ad
Occhiobello. La forza delle acque, ormai incontenibile, forzò gli argini
provocando una rotta tremenda ed allagando tutta la provincia di Rovigo ed una
parte di quelle di Mantova e Venezia. Nella notte del 18 novembre venne dato
l’ordine di evacuare Rovigo. La stessa sorte toccò ad Adria, Cavarzere e Loreo,
che vennero completamente allagate il 19 novembre. La piena si scaricò
finalmente in mare martedì 20 novembre. Complessivamente si registrarono 88
vittime e migliaia di persone persero tutto.
Dopo oltre quarant’anni di
relativa tranquillità, nel novembre 1994 il Po tornò a fare paura. Le zone
maggiormente colpite questa volta furono quelle occidentali del bacino del
Grande fiume: alessandrino, torinese, cuneese ed artigiano. In soli tre giorni
piovosi, compresi tra il 3 ed il 6 del mese, in quelle aree cadde più pioggia
di quella caduta in un arco di tempo doppio nel 1951.
La piena del Po e di alcuni dei suoi affluenti fu rapida e violenta e gli esiti furono disastrosi. Nel piacentino il fiume raggiunse la considerevole quota di9,88 m sopra lo zero
idrometrico (a soli 37 cm
dal livello del ’51). Le vittime furono 70 ed i danni furono stimati in circa
40.000 miliardi di lire.
Allagato il nord ovest italiano, le acque del fiume scesero verso valle provocando problemi e soprattutto molta paura sino al delta. A dare le maggiori preoccupazioni furono soprattutto i numerosi fontanazzi, sorgenti create da infiltrazioni d’acqua, che minarono la stabilità della base degli argini. Uno di questi, formatosi a Carbonarola, diede molto lavoro ai tanti volontari accorsi per sorvegliare la situazione e per dare una mano negli interventi di controllo della piena. Grazie alla loro opera, nella zona di Carbonara fortunatamente non ci furono danni particolari
La piena del Po e di alcuni dei suoi affluenti fu rapida e violenta e gli esiti furono disastrosi. Nel piacentino il fiume raggiunse la considerevole quota di
Allagato il nord ovest italiano, le acque del fiume scesero verso valle provocando problemi e soprattutto molta paura sino al delta. A dare le maggiori preoccupazioni furono soprattutto i numerosi fontanazzi, sorgenti create da infiltrazioni d’acqua, che minarono la stabilità della base degli argini. Uno di questi, formatosi a Carbonarola, diede molto lavoro ai tanti volontari accorsi per sorvegliare la situazione e per dare una mano negli interventi di controllo della piena. Grazie alla loro opera, nella zona di Carbonara fortunatamente non ci furono danni particolari
"La piena del
millennio". E' così che molte cronache ricordano la straordinaria e
terribile piena dell'ottobre 2000,
l 'ultima pericolosa in ordine di tempo ma, almeno da
quando vengono effettuate misurazioni, la prima come intensità.
Tutto ebbe inizio il 14 ottobre
con intense precipitazioni sul nord ovest italiano che si protrassero anche nei
giorni successivi. I primi danni di rilievo, dovuti ad esondazioni della Dora
Baltea, si verificarono domenica 15
in Val d'Aosta. In poche ore un'enorme massa d'acqua si
riversò nel Po, che il 17 ruppe alcuni argini nel torinese provocando danni
ingenti.
La pioggia battente fece
raggiungere al Grande Fiume dei livelli record. Alle ore 18 di martedì 17
ottobre, il Po arrivò a 10,50
metri sopra lo zero idrometrico a Piacenza, misura mai
registrata (il primato precedente si ebbe nel 1951 con 10,25 metri ). Nei
giorni successivi la piena si mosse verso valle devastando le infrastrutture
poste sulla sua strada, allagando le campagne e costringendo le autorità ad
evacuare migliaia di persone.
Mercoledì 18 la situazione si
fece critica anche nel mantovano. Superata ampiamente la soglia di guardia, le
acque iniziarono a creare notevoli preoccupazioni. In attesa di raggiungere il
massimo della piena, previsto per il giorno successivo, si allertò la Protezione civile e ci
si preparò a qualsiasi eventualità.
La mattina successiva, il fiume
ruppe in due punti l'argine golenale tra Borgofranco sul Po e Carbonara. Non
accadeva dal 1951. Nel giro di poche ore, l'intera golena fu ricoperta da quasi
10 metri
d'acqua. Nel corso della notte successiva, con il Po al livello massimo,
cedette anche l'argine golenale di Carbonarola.
Venerdì 20 si aprì con un
fontanazzo sviluppatosi a Carbonarola intorno alle 10 del mattino. La
pericolosa infiltrazione alla base dell'argine maestro fu bloccata solamente
con gli sforzi di decine di volontari, molti dei quali reduci da una notte di
ronde sugli argini.
Gradualmente l'emergenza si
spostò verso il mare. I problemi maggiori si ebbero a Pontelagoscuro, dove
l'acqua arrivò a lambire il ponte ferroviario sul Po. Per evitare un crollo
potenzialmente disastroso, fu necessario sollevare l'intera struttura con
un'inedita e spettacolare operazione di ingegneria.
Dopo alcuni giorni, la situazione
tornò lentamente nella norma. Il bilancio fu drammatico: una ventina di morti,
migliaia di ettari di campagna allagati, decine di migliaia di sfollati,
migliaia miliardi di lire di danni alle colture e alle infrastrutture.